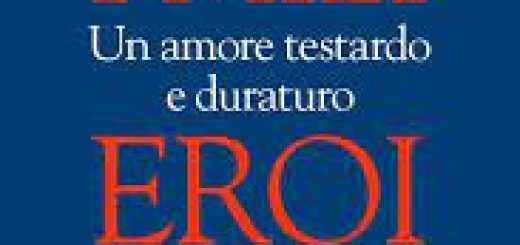Titolo: Fiabe (Kinder- und Hausmärchen)
Autore: Jacob e Wilhelm Grimm
Anno di pubblicazione: 1812
Edizione usata per la recensione: Einaudi, 2005
(Recensione a cura di Saverio Simonelli)
Sette edizioni per quarantacinque anni di studio: dal 1812 al 1857. Rappresentano davvero il lavoro di una vita le Fiabe per bambini e del focolare di Jacob e Wilhelm Grimm, che furono però anzitutto filologi, linguisti, indagatori puntuali del patrimonio letterario della Germania, ma che con la loro autorevolezza e preparazione incoraggiarono e di fatto sostennero la pubblicazione di studi e grammatiche di praticamente tutte le lingue europee in quel secolo irripetibile in cui miracolosamente l’interesse degli studiosi si saldò all’afflato di riscoperta delle radici e del patrimonio culturale dei popoli del Continente.
Le fiabe sono così un’opera del cuore che accompagnò i loro studi e ne fu insieme conseguenza. Sulla scia del giurista Karl von Savigny, che all’Università di Marburg gli insegnò il lavoro sulle fonti, Jacob e Wilhelm Grimm intesero la raccolta delle fiabe non come un’opera da folkloristi ma come la valorizzazione di un patrimonio anzitutto di narrazioni e concezioni del mondo, la restituzione del sentore, della Weltanschauung di un’epoca in cui gli anonimi autori delle fiabe credevano realmente che nel mondo ci fossero all’opera entità misteriose, forze inconoscibili simbolicamente rappresentate da giganti, fate, nani, streghe, incantesimi.
Duecento sono le fiabe che nel corso di due secoli hanno conquistato il mondo e quasi colonizzato l’immaginario di generazioni di bambini. Eppure questo viaggio non è stato così agevole. Tutt’altro.
Alla vigilia del natale del 1812 le Fiabe vengono pubblicate dall’editore Reimer che ne stampa 900 copie al prezzo di 1 tallero e 18 groschen. Il volume, che consta di 475 pagine in ottavo, va esaurito in tre anni ad una media di 300 copie all’anno che per il periodo è decisamente un andamento positivo. Questi numeri incoraggiano autori ed editore a pubblicare il secondo volume che arriva in libreria nel 1815 ma senza ripetere il buon risultato del primo. Molto probabilmente dopo il Congresso di Vienna e la restaurazione la crisi economica raffredda gli entusiasmi dei lettori, fatto sta che la media vendite si riduce drasticamente del 50%. Di qui segue una lunga controversia con Reimer e la ricerca di un nuovo editore. Ma le cose non cambianmo, anzi l’edizione del 1819, che racchiude primo e secondo volume a un prezzo di 3 talleri e 14 groschen andrà inizialmente andrà anche peggio e impiegherà 20 anni ad esaurirsi. La vera svolta commerciale per i Grimm si verifica con la pubblicazione dell’edizione ridotta e illustrata del 1825 esemplata sulla versione inglese che in Gran bretagna frutta al locale editore 15.000 sterline. Questa edizione ‘minore’ dell’opera, quasi un best of per dirla in termini moderni, presenta solo 50 fiabe con i disegni del terzo fratello Ludwig. Si deve comunque attendere la fine del secolo e l’inizio del successivo per trovare le fiabe in vetta alle classifiche di vendita. Ma di lì in avanti il trionfo è enorme e globale. Già negli ultimi decenni dell’Ottocento le fiabe compaiono stabilmente nei testi di lettura per le scuole in Prussia, mentre dal 1880 vengono utilizzate negli Stati Uniti nei corsi di tedesco. In Germania e in Austria si contano 250 ristampe tra il 1912 e il 1935. Poi ci penserà Walt Disney: la versione di Biancaneve per cartoni animati è infatti del 1937.
Ma la forza di queste storie sta nella capacità di tratteggiare squarci di mondo senza tempo, panorami smisurati ed indistinti in cui quasi come in un’istantanea si compiono destini fatali, grandiosi, misteriosi. Boschi, castelli, pianure sconfinate senza alcuna topografia, senza mappe o indicazioni specifiche. Una scena appena accennata sulla quale sono proiettate per un attimo figure che di lì entrano per sempre nell’immaginazione del lettore perché vivono, condensate in poche righe, vicende comuni a chiunque ma impensabili per la loro portata simbolica. Biancaneve, il principe ranocchio, i musicanti di Brema, Cappuccetto Rosso e ancora nascite, morti, risurrezioni, trame diaboliche miracoli e salvezze inattese. La fiaba non risparmia crudeltà, tremori, paure: vuole far capire a chi legge che la strada verso la maturazione umana è irta di prove che comunque si possono superare.
In ogni caso il più delle volte ciò che salva nella fiaba è un episodio imprevisto, isolato, gratuito, inatteso. Il cacciatore che passa davanti alla casa della nonna, l’uccello che si posa sul tetto della casina della strega di Hansel e Gretel, la fata di Cenerentola.
Ecco allora il nodo: c’è nelle fiabe l’idea che alla fine quel mondo oscuro, misterioso e pieno di pericoli, dove perfino un padre ti può abbandonare, possa essere vissuto nella speranza di un riscatto, di un senso altrettanto misterioso che forse ti accompagna ma che bisogna decifrare nell’attimo in cui viene rappresentato da un fatto, un passaggio, un lampo nel cielo.
Il fine della narrazione quindi è la salvezza, non il conseguimento di uno stile di vita, nè di un’aspettativa di futuro. E’ un mondo rude e crudo quello delle fiabe, ma dove alla fine sperare e fare il bene viene premiato non per una frettolosa spolverata di buoni sentimenti ma perché l’anelito verso la giustizia è più forte e trova la ricompensa: gli umili vengono esaltati in quel vissero felici e contenti, in quella svolta conclusiva delle storie che dà ancora oggi una sensazione forte di liberazione, di salvezza.
Finché c’è vita nella fiaba e finché ci sono righe che si separano dalla conclusione c’è sempre una possibilità. E questa se ci pensiamo è una grande lezione di speranza. E’ come se tutto l’Universo avesse l’odore dei bambini in fasce: deve essere accudito aspettando la prossima sorpresa, attrezzati anche per l’inverosimile.