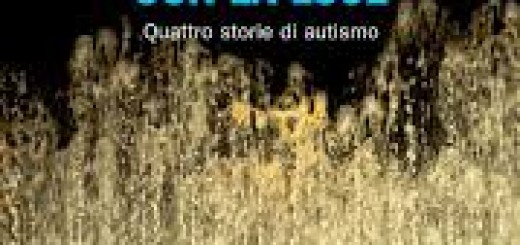Titolo: De vita beata
Autore: Seneca
Anno di scrittura: 58 d.C.
Edizione usata per la recensione: Newton Compton, 2013 (Seneca, L’arte di essere felici)
I soldi fanno la felicità? E uscire la sera per solenni mangiate e bevute? E possedere l’ultimo ammennicolo tecnologico? A volte siamo portati a credere che siano domande peculiari della nostra civiltà materialista, invece già per gli antichi erano fondamentali nel dibattito su come si possa essere felici, il ché a sua volta è senza dubbio una delle questioni più dibattute di ogni tempo.
In fondo, c’è qualcosa che conti di più della felicità? Ne parla diffusamente nel De vita beata lo stoico latino Lucio Anneo Seneca, il quale, benché notoriamente ricco sfondato, sosteneva che la felicità derivasse da ben altre fonti e in particolare da Virtù e Ragione. Le traduzioni del titolo più correnti contengono il termine “felicità” (L’arte di essere felici, Newton Compton; Sulla felicità, BUR…), anche se ad essere rigorosi il concetto è più ampio e la traduzione letterale “Riguardo alla vita felice” lo cala in una dimensione ancora più ampia. Seneca, infatti, non si concentra su condizioni episodiche di gioia o di letizia, ma su una stabile condizione di vita serena, anzi beata, che non a caso è di norma definita nel testo come il summum bonum, cioè il sommo bene. È l’eudomonia, la scienza della felicità che consiste nell’agire in modo virtuoso e saggio per essere felici, nel sapere che nelle buone azioni sta la felicità.
A proposito di traduzione, siccome il pretesto per la nostra recensione è il grande successo di vendite dell’edizione a 99 centesimi curata da Mario Scaffidi Abbate per Newton Compton, spendiamo due parole sulla pubblicazione. L’economico libretto ha l’indubbio pregio di avere il testo a fronte (per chi ama confrontarsi con l’originale) ed una traduzione abbastanza puntuale che rappresenta un valido ausilio per seguire la stesura latina. Per una lettura informativa è più che sufficiente (benché io nutra riserve su alcuni passaggi), ma l’introduzione è breve e sommaria, mentre l’apparato di note, che talora sono necessarie a comprendere i molti riferimenti di cui il coltissimo Seneca dissemina l’opera, è stringato e di non facile consultazione (le note si trovano a fondo libro – il che garantisce una più semplice impaginazione – e non sempre è chiaro a quale passaggio si riferiscano). Insomma, rispetto al costo si tratta di una proposta più che dignitosa, ma non bisogna avere troppe aspettative.
Torniamo al testo. Il nostro autore parte dal presupposto, centrale nella filosofia antica, che per raggiungere la felicità si debba prendere la strada giusta, pena l’allontanarsi da essa. Pare scontato ma, come egli nota, i più seguono le scelte della massa secondo apparenza, le quali però sono fallaci. Seneca sembra dire: veramente pensate di essere più felici se comprate l’Ipod, lo smartphone, l’auto sportiva, i jeans all’ultimo grido? O ancora se conquistate partner in serie e la sera, in comitiva, bevete sei birre e due vodke? Allora siete stolti! La felicità non viene dall’accumulo dei piaceri, che anzi sommandosi portano all’infelicità: di coloro che ad essi si abbandonano esse in voluptatibus dices, non tamen illis bene erit (potrai dire che sono immersi nei piaceri, non che sono felici, XI).
Seneca, poi, conosceva bene la critica che molti contemporanei gli muovevano: predicava contro i piaceri, ma viveva nel lusso. La sua difesa (che occupa quasi metà dell’opera) si basa su molti argomenti, il più celebre dei quali è che divitiae meae sunt, tu divitiarum est (le ricchezze sono mie, tu appartieni alle ricchezze XXII, 4): la differenza, insomma, sta fra chi si lascia possedere dalle ricchezze e chi le domina, ne gode senza lasciarsi condizionare. Il che, però, è estremamente difficile: come i giaguari tenuti in qualità di animali domestici rischiano di sbranare i padroni (ecco una delle molte suggestive similitudini che puntellano il testo), così i piaceri rischiano di prendere il sopravvento, al punto che ille minor ac plurimum servus est quem felicem vulgus appellat (è più piccolo e schiavo colui che il volgo chiama felice, XIV, 4), dove perdere la libertà e farsi schiavo significa rinunciare alla propria stessa umanità. E allora perché Seneca non si priva delle sue ricchezze? Ma diamine, perché sono comunque piacevoli! In modo politicamente poco corretto, egli spiega che come è meglio essere alti piuttosto che bassi, anche se nell’altezza non risiede la felicità, così è meglio essere ricchi anziché poveri.
Non basta: è perfino più facile per un ricco essere virtuoso di quanto lo sia per un povero. E siccome Seneca non si stanca di ripetere che la virtù è la vera fonte del sommo bene, della condizione di stabile serenità cui si deve agognare, è evidente che i ricchi sono favoriti anche nel filosofeggiare – sebbene il saggio sia l’unico che possa essere felice (con maggiore o minore facilità) sia egli ricco o povero, perché sa agire secondo natura.
Tweet: Seneca, De vita beata: i soldi non fanno la felicità. Però aiutano #GrandiRiflessi