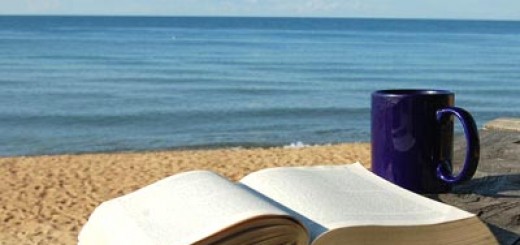Nello spazio Incubatore assistiamo alla presentazione di Mattanza dell’incanto, l’ultimo libro di poesie di Nicola Vacca pubblicato per la casa editrice Marco Saya. Il libro è composto di tracce brevi, parole che penetrano come ferite e ci parlano della nostra società, dell’uomo di oggi e della sua solitudine, ma anche della possibilità, della necessità di reagire. L’autore è stato sottoposto al fuoco incrociato delle domande di Giuseppe Iannozzi e subito dopo delle nostre di Amanti dei Libri. Rispondendo da vero poeta.
Nello spazio Incubatore assistiamo alla presentazione di Mattanza dell’incanto, l’ultimo libro di poesie di Nicola Vacca pubblicato per la casa editrice Marco Saya. Il libro è composto di tracce brevi, parole che penetrano come ferite e ci parlano della nostra società, dell’uomo di oggi e della sua solitudine, ma anche della possibilità, della necessità di reagire. L’autore è stato sottoposto al fuoco incrociato delle domande di Giuseppe Iannozzi e subito dopo delle nostre di Amanti dei Libri. Rispondendo da vero poeta.
Nicola, puoi spiegarci il perché questo titolo che è un po’ una contraddizione?
Libro è un libro scritto per fare rumore. Io da un po’ di tempo vivo la scrittura come esperienza totale. Scrivo per svegliare e ogni riga, ogni verso deve essere come un chiodo, una ferita. Una parola vera che testimoni la vita reale, provida di una verità disarmante. Abbiamo bisogno di eresie, di navigare in direzione ostinata e contraria. Ci vuole impegno civile che non è quello degli anni 60’: col mio impegno io voglio pugnalare il mio tempo, colpirlo con la mia parola che diventa verso, che deve attraversare la vita liquida di questi giorni per immortalare il senso di questo nichilismo che stiamo attraversando.
Nei tuoi versi emerge spesso la solitudine. A che tipo di solitudine in particolare vuoi riferirti?
La solitudine a cui faccio riferimento nei miei versi rimanda alla devastante angoscia dell’uomo del mio tempo che non è più capace di amare, di comunicare, di ascoltare l’altro nella nuda schiettezza della parole. Non siamo più in grado di togliere la maschera e mostrarci nudi ma veri, siamo incapaci di vivere una vita come quella che il quotidiano ci offre. È importante tornare in una comunità, in una civiltà delle anime in una piazza concreta in cui l’incontro possa favorire lo scambio fra persone che siano in grado di amarsi.
Come può l’individuo prendere coscienza di sé, del mondo che guarda con cinismo e a volte distrazione? Come si pone il poeta nei confronti di questo problema?
Diceva Ezra Pound «il compito del poeta deve essere quello di riempire il caos». E i poeti hanno il grande compito di testimoniare il caos senza moralizzare e senza diventare nichilisti. Noi dobbiamo attraversare il caos e avversarlo con la forza della scrittura.
Le tue righe trasudano di una schietta lucidità e sono un po’ una fotografia del dolore. Ma come possono essere usate per migliorare lo spazio intorno?
Noi scrittori non possiamo che credere nelle parole. L’unica religione che uno scrittore può avere è la parola. La parola deve essere il mezzo. Nella sua crudeltà più schietta, pur nella sua crudeltà, l’importante è che sia scritta e rovesciata senza dar conto agli opportunisti o agli ipocriti. Diceva Pier Paolo Pasolini «Io sono nato per testimoniare lo scandalo». Io devo molto a questi versi. Il poeta deve essere testimone dello scandalo e portatore sano di eresia. Quando ho pensato a questo libro o pensato anche alla situazione attuale e ovviamente il mio pensiero non poteva non andare anche alla decadenza del costume politico che ci sta soffocando.
L’idea è che a poesia sia per i pazzi o chi non vuole vedere la realtà. Allora chi è davvero il poeta? E perché la poesia, una poesia forte, come quella di Alda Merini, viene considerata, ma non abbastanza?
Io e Alda Merini soprattutto nell’ultimo periodo ci sentivamo per telefono e spesso l’andavo a trovare. Avevamo a quel tempo un rapporto quasi quotidiano. Quando andavo a trovarla ero in adorazione e per questo quando è morta ho scritto questa poesia (La parte della porta accanto NdR). Il giorno della sua morte ricordo che l’editore del giornale per cui lavoravo mi ha chiamato per dirmi di scrivere qualcosa su di lei. Io che avevo la scrittura facile mi misi al computer: passai una notte a piangere senza buttar giù una sola riga. Solo all’alba, finalmente, scrissi. Mi ha insegnato una cosa fondamentale: mi diceva «la poesia deve educare il cuore. Se la poesia non educa il cuore è cronaca». Il poeta deve rendere nuda ed essenziale la parola, deve far rabbrividire la pelle e poi restare addosso.
Possiamo dire dunque che la poesia non è mai un atto forte, ma un atto di ribellione?
La poesia oggi è un atto impuro di ribellione, un atto di resistenza. Noi abbiamo il dovere di capire la pienezza di tutto questo vuoto che ci circonda. Io faccio questo viaggio nella notte per riempire lo spazio con la parole che resiste, con la parola che riempie il vuoto. Chi scrive dovrebbe saper poi ascoltare gli altri. Io vivo di contaminazioni. Ho avuto la possibilità di incontrare scrittori, poeti, letterati e ho conosciuto bellissime persone che amano la scrittura più di se stessi.
Cosa ti ha spinto a scrivere la prima poesia? Come l’hai scoperta?
Ho sempre amato scrivere leggere, ho iniziato circa a 15-16, dunque ero abituato a circondarmi di libri. La passione è nata di conseguenza, è stata fisiologica. Nato con la penna in mano, appena ho avuto il dono della ragione ho capito che era nell’ordine delle cose scrivere. Il dolore è stato il titolo della mia prima poesia, era il sentimento fondamentale in quel momento: stavo leggendo Pavese e ne ero molto influenzato. L’ho dedicata a lui.
C’è mai stato un momento in cui ti sei sentito sommerso da ciò che percepivi? Che hai pensato di non riuscire a di esprimerlo?
Sono un poeta immediato che amo la naturalezza, il mio maestro è stato Ungaretti, padre della schiettezza. Da quando ho iniziato a scrivere penso sempre alla naturalezza, parole che siano vere e non a tavolino: le migliori sono quelle che ci da la vita, sono nello scrigno dei giorni che il tempo ci offre. Abbiamo le parole e il quotidiano che è motivo di indagine
Un’ultima domanda: ami citare i pensieri dei grandi autori, ma qual è la tua citazione preferita tra tutte?
La morte si sconta vivendo. (Ungaretti)