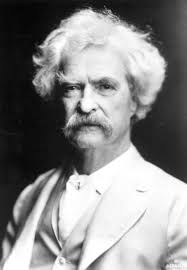
Autore: Twain Mark
“Un americano alla corte di Re Artù” è quasi un “binomio fantastico”, un’accoppiata di due elementi che proprio non potrebbero stare assieme: il medioevo, il cavalleresco, l’epico si confrontano con il moderno, il pragmatismo, la concretezza. Nel titolo originale (e in alcune traduzioni italiane), tra l’altro, l’ “americano” è uno “yankee”, cioè uno della parte nord degli USA, quella non solo più industriale e progredita, ma anche più illuminata.
Il punto di partenza della storia sembra una rêverie di bambino: “se io, con le mie conoscenze, mi trovassi in un’epoca antica, cosa sarei in grado di combinare”? Una fantasticheria più volte sfruttata e che si presta ad esiti ironici: pensiamo al film Non ci resta che piangere, in cui, proprio come nel libro di Mark Twain, i protagonisti si trovano proiettati in un lontano passato senza sapere bene perché. Solo che, invece di due simpatici pasticcioni come Benigni e Troisi, le cui idee sul funzionamento di treni e lampadine sono quanto mai confuse, qui il balzo nel passato coinvolge Hank, un tecnico abilissimo. Questi, dopo essersi cavato d’impaccio impressionando i medievali con un trucco scientifico che lo qualifica agli occhi di tutti come un mago molto più potente di Merlino, riesce in breve a guadagnarsi un ruolo di alto comando, tanto che viene soprannominato “il Capo”. Interessante che, sebbene sia considerato il più grande mago in circolazione, usa semplicemente le sue conoscenze tecnico-scientifiche: magia è quel che non si riesce a spiegare – incluso un colpo di pistola. Merlino, nella versione del narratore in prima persona Hank, sarebbe quindi un imbroglione e i cavalieri della Tavola Rotonda degli sbruffoni, dalle cui invenzioni nasce l’alone eroico che li accompagna.
Da questa descrizione, Un americano alla corte di Re Artù potrebbe sembrare un libro per ragazzini, o al massimo dedicato ad un intrattenimento leggero, e senza dubbio ha queste virtù: io lo lessi con gran divertimento a dodici anni, pur senza cogliere grandi implicazioni. Invece, Mark Twain brandisce l’arma della satira e i suoi contemporanei non sono trattati molto meglio dei vituperati medioevali, che pure il narratore non si stanca di schernire come: ignoranti, creduloni, violenti, sciocchi, ingenui, prevaricatori, sbruffoni, sporchi, oscurantisti e chi più ne ha più ne metta.
Intendiamoci, il tono lieve e divertente non è (quasi) mai abbandonato sino alla tragica conclusione, e le trovate esilaranti si susseguono. Però, il gioco si fa squisitamente complesso, ed è favorito dall’uso di un narratore in prima persona nei panni del quale, in prima istanza, ci possiamo identificare, ma dal quale a ben pensare l’autore assume un distacco critico. Noi leggiamo l’esplicita stigmatizzazione dei bifolchi medioevali, ma davvero un polemista raffinato come Twain potrebbe trovare interessante prendere in giro dei buzzurri defunti da un millennio e mezzo, e per di più ricostruiti in modo storicamente discutibile? È ovvio che, sotto le mentite (e bisunte) spoglie degli inglesi del VI secolo si celano i suoi contemporanei, dei quali Hank è un perfetto esponente. Del resto, se nel VI secolo esisteva ancora la schiavitù, e su essa si riflette, non dimentichiamo che la guerra di secessione americana era finita da poco più di un ventennio.
Dopo averci intrattenuto con i fraintendimenti iniziali, Hank ci illustra il suo programma: si mette in testa, infatti, di non limitarsi a portare la tecnica moderna (a vantaggio dei suoi nuovi compatrioti e per sua stessa comodità), ma anche di cambiare la mentalità del volgo, oppressa, a suo dire, da magia e religione – due “nemici della scienza” non certo così dimenticati nel XIX secolo.
Cerca, ad esempio, di spiegare ad uno zuccone di fabbro perché il liberismo, in economia, sia meglio del protezionismo. La tesi di Hank è che il fabbro sia più povero di un suo collega di Camelot (già investita dalla nuova ondata economica) sebbene guadagni il doppio, perché paga ogni bene quasi il triplo di quanto non costi a Camelot. A seguito di vari ragionamenti, il fabbro conclude la discussione inseguendolo con una grossa mazza. Usiamo questo esempio fra i molti (anche più spassosi, come la creazione del primo giornale fra lo stupore degli amanuensi che di norma dedicavano mesi a copiare ciò che si vedono in mano ogni giorno in centinaia di copie) per tre motivi: perché ci mostra come i concetti affrontati non siano solo “per bambini”; perché la teoria “moderna” di Hank sarebbe criticata anche da molti economisti dei tempi sia suoi, sia nostri; ma soprattutto perché è un chiaro esempio di come l’appassionata opera di evangelizzazione di Hank trovi ostinate, e talora violente, resistenze.
Il punto, inatteso per in narratore, è che i medioevali sono piuttosto convinti di ciò in cui credono, e non sono disposti a lasciarsi guidare dalla presunta mente superiore. Anzi, si arriverà ad uno scontro finale cruentissimo fra seguaci di Hank e cavalleria, che non avrà né vinti, né vincitori, ma si risolverà in un massacro, per cui il lettore non potrà fare a meno di pensare che, per gli abitanti del VI secolo, sarebbe stato immensamente meglio non avere contatti con quelli del XIX.
Ecco che la critica, a saper leggere oltre la sicumera del narratore, yankee fino al midollo, va tanto agli arretrati medioevali quanto ai sedicenti modernizzatori: pare di sentir l’eco del colonialismo, con le sue pretese di civilizzare i barbari (opprimendoli e sfruttandoli), ma anche di certe attuali guerre per “esportare la democrazia”, mosse per principi forse in sé apprezzabili, ma gravide di conseguenze nefaste perché poco tengono conto della realtà del luogo in cui si combattono.
Hank sarà riportato nel suo tempo, alla fine della battaglia, da un incantesimo di Merlino. Ecco che tutto quanto pareva assodato, si rivela dubbio: Merlino, dunque, è un vero incantatore? Le convinzioni di Hank erano solo sue pretese non verificate? O tutta la storia è stata un delirio di un folle?
Comunque, una storia piacevole, interessante ed istruttiva.




