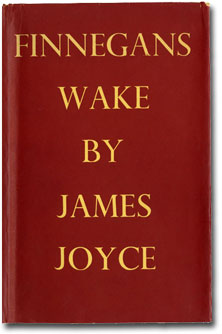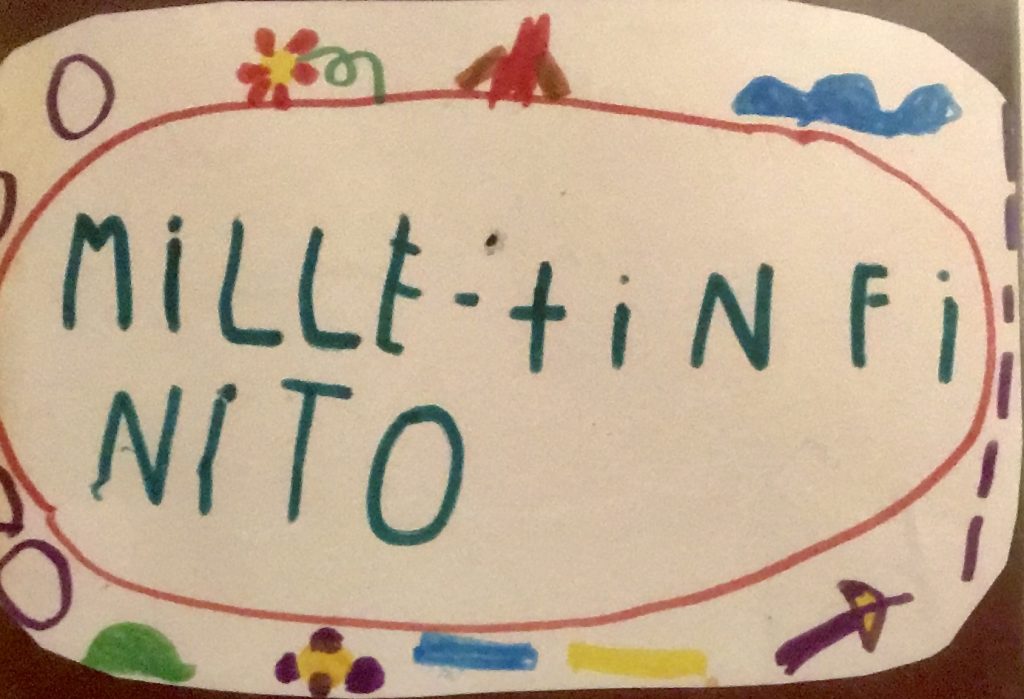
Degli autopostali, i belli e chissà se unici al mondo dalla livrea tuorlo d’uovo delle poste svizzere, il primo, con destinazione Chiavenna, parte dalla stazione di Sankt Moritz alle sei e diciotto antimeridiane. Alle cinque e cinquantatré, sempre antimeridiane, parte il secondo treno del giorno da Celerina per Sankt Moritz stazione. Per esattezza informativa il primo dei treni su questa stessa tratta di precisi cinque minuti, è alle quattro e cinquantatré. AC non era in grado di enumerare a memoria le volte che aveva preso un treno e consultato un orario ferroviario ; consultarlo era divenuto anzi, per un certo e lungo periodo, un gioco meditativo : nello spesso volume dell’orario europeo combinava cambi e combinazioni di corse durch den Tag durch die Nacht durch den Tag, notteegiorno, come un alfiere Cristoforo Rilke ma fino a mete immaginose, o cimmerie, a Husum per esempio, die graue Stadt am Meer, la grigia città sul mare di Theodor Storm che lì al confine della Frisonia con la Danimarca era nato e AC non ne aveva appreso più del nome e quella epigrafe da elegèta delle nebbie ma di quello storm, chi fosse e perché, non si era mai occupato ; in definitiva si trattava di viaggiare senza muoversi di casa come Des Esseintes, il protagonista di Huysmans nell’À rebours che, dopo una cena inglese al Caffè Inglese di Parigi leggendo un bedecker su Londra, decide alla fine che a Londra c’è ormai stato, piglia e salta in fiàcchere e torna nella zona di conforto della sua magione parigina. AC amava da ragazzo quei viaggi impassibili, sul posto, resi possibili da una acuta analisi degli orari. Semmai la difficoltà era costituita dal tempo. In treno però una volta era arrivato a Lisbona, per il suo primo incarico ; ci era riuscito davvero e, se non ricordiamo male, in tre giorni. A quel tempo il volo sarebbe stato come morire per lui. Anzi continuò ad esserlo ancora per un lungo periodo – prendere un aereo è fare testamento e sono ancora troppo superstite per accettarlo, asseriva con un tono che svelava la polemica dell’intenzione – finché non realizzò che qualunque andare e venire, fosse pure a piedi o in bici, comportava una percentuale variabile di rischio mortale : per il resto anche a restare, fermi, in casa, seduti al pianoforte, non si poteva sapere, lo scrisse Pessoa il giorno prima della sua morte, del what tomorrow will bring. Lui, in uno dei suoi molti taccuini di pensierini serali, il to sleep, perchance to dream dell’amleto lo aveva parafrasato in questo modo, viaggiare forse morire senza sognare, amen. Amen. In ogni modo, da sempre e in occasione di qualsiasi partenza AC non poteva non svegliarsi almeno due ore prima, anche tre. Ore che impiegava per ripulirsi con precisione di ossesso – non è inutile ricordare qui che usava una spugnetta specifica per ogni parte del corpo, una, piccinissima, persino per le orecchie – e per fare una sua rigorosa colazione, domestica come una devozione, un caffè forte prima di tutto, poi con calma pane imburrato con generosità contraria a qualsiasi raccomandazione medica e inzuppato in un tè carico ma con latte ; mai avrebbe potuto ma anche solo pensare a un cappuccino con un cornetto, la brioche della più parte degli italiani, in piedi al banco di un caffè ; nemmeno nel più bello dei caffè ; del resto considerava un’aberrazione in sé il cappuccino, quel di cui aveva visto bearsi torme di turisti incolti a Bellagio sgranocchiando pizza. Checché, caffè nero per lui e il tè al contrario, nero sì ma appunto mescolato non con una nuvola ma con un temporale di latte. All’epoca del nostro racconto c’era peraltro da aggiungere a questo rituale di piacere, quello del dovere, ovvero di assumere alcuni medicinali, il betabloccante, l’aspirinetta, il palmetto, farmaci di ordinaria terapia alla sua età e ringraziava il caso che gli aveva mantenuto una prostata in giudiziose dimensioni. Sicché, al chiudere gli occhi dopo un’ultima fugace lettura degli Enterrements della Rosìni, il comando di svegliarsi fu per quindici minuti alle quattro, a notte insomma. Nell’anno del diploma finale di conservatorio, aveva addestrato con successo il suo cervello ad addormentarsi a comando e a svegliarsi di conseguenza e, a differenza dei suoi compagni sempre insonnoliti intorno a un cappuccino, anche alle dieci, lui, alle sette del mattino era una bettolina dal diesel caldo e ben oliato che sfrecciasse tra bastimenti fermi agli ormeggi. Il proprio successo riteneva di doverlo anche a questo disciplinare un po’ da monaco ma senza mistica, se non quella del lavoro. Del suo servizio militare, ricordava che nella sua compagnia di reclute, era l’unico sempre sveglio e pronto cinque minuti prima della muta di guardia, e all’appello del mattino, sempre tra i primi, ben lavato, scarpe scintillanti, pettinato, sbarbato, inappuntabile nella divisa, perfetti il basco calato sull’orecchio destro e al collo il fazzoletto bicolore del battaglione di preciso sul pomo d’adamo, ah lui il non popolare occhialuto scritturale che però, ai tiri, mostrava un’assoluta padronanza dell’arma e del bersaglio : dieci su dieci con i fucili di allora, i Garrand tutti d’acciaio e di legno masselli.
In viaggio peraltro, soprattutto nel noiosissimo tratto tra Colico e Milano contava di recuperare un po’ di sonno, già lo sapeva. Nel percorso svizzero e poi fino a Colico e in quella stagione di ottobre ormai alla fine, non si sarebbe per nulla al mondo perso lo spettacolo del levar del sole, dei cambi di temperatura dei colori, del risveglio alle luce delle foreste e dei laghi fino al Maloja, e il sonno persistente delle costruzioni umane di cui si sarebbe beato spiare ora qua ora là un’unico lume, quello delle cucine, le cucine del giorno in divenire. L’alba ; AC la considerava un dono personale, fatto a lui specialmente da una natura di buon umore e ciò benché all’aria aperta si rendesse conto che i voli, i gridi, i richiami degli animali più grandi e l’operoso destarsi degli insetti, avevano un solo scopo, l’ossessione del cibo, la grinta della fame ; sapeva benissimo che per moltissimi, cibo erano altri animali che, dal canto loro, sapevano altrettanto bene di essere cibo per altri ancora e che quindi, oltre a cercare di nutrirsi occorreva trovare espedienti per nascondersi all’occhio rapace altrui. L’alba confondeva i trilli, i richiami col grido delle agonie della notte, oh ringsum dunkle Nacht… oh intorno oscura notte. Negli incontri dei campionati tra natura e cultura che in lui si svolgevano da sempre, li vinceva o andava a pareggio la seconda benché la prima gli si presentasse con una veste non idealizzata al completo o romantica, ovvero, per usare un termine più ruvido, in una versione soft-core ; della scienza conosceva poco,giusto alcune radure per pic-nic domenicali, i suoi territori lo incuriosivano senza che si fosse impadronito dei mezzi per esplorarli con l’inutile eccezione della pur vasta meccanica computazionale della musica, un’algebra indispensabile a sé stessa di cui aveva dovuto apprendere e conosceva in anticipo e a memoria tutte le incognite e variabili. Da questi pensierini non privi di sfumature umoristiche, alla Zarathustra però, non poteva non atterrare sull’evidenza sperimentale che la morte riposare riposa di rado o mai o per finta, e che perpetra il suo perspicace ufficio indifferente all’ora, sia pure essa legale ; e ciò lo ricondusse al motivo di tutta quella fatica, di svegliarsi e correre nell’alba fino a Milano dove aveva fatto il conto sarebbe arrivato, e doveva arrivare, in tempo per il funerale di Dora, nome proprio di persona che dà un tocco di inutile colore al sospetto che possa avere un’affinità onomastica con il personaggio di Freud ; lasciamo chi vuole a lavorare di fantasia e tiriamo innanzi.
Dora dunque, era madre unica di un figlio unico ovvero del suo amico storico, Pilatus ; è ignota e non indagabile la ragione di questo che a qualunque lettore sembrerà per sé un soprannome, e ignoto e non indagabile è il perché a Milano chiunque sia registrato all’anagrafe con più di un trisillabo dalla materna in poi viene strozzato d’ufficio in un bi o monosillabo : sicché Latus o Pilus, talvolta Tus. Dora era morta due giorni prima della merenda da Hanselmann, a novantanove anni. Bene. E adesso siamo costretti ad ammettere che il racconto prende qui una piega antipatica, chissà se di gossip o potin, vietato leggere póutin perché è francese e suona pót’æn ; di chiacchiera inutile insomma ma, aggiungiamo qui con la prudenza che il caso impone, non del tutto priva di interesse drammaturgico tra le quinte nel teatrino di questa vita vissuta. AC non aveva mai sopportato Dora, sempre antipatica ai suoi occhi, di bambino prima, poi di adolescente, e infine di uomo ; sempre trovato respingente il suo aspetto tondo di rouquine, ossia di rossa e grassoccia moderata, lentigginosa e lattiginosa, cikciak sempre a piedi nudi in casa, sempre sbracciata, spesso troppo sudata, fosse o non fosse a causa di una menopausa di cui Dora, ad ogni inopportuna occasione sbandierava sintomi ed eziologia, come se fosse un certificato di femminilità esperta ; più di tutto di Dora, e di sicuro qualcuno versato in psicologia strologherà su questo dato, infastidivano AC fino a suscitarne il sarcasmo, le sue tremende poppe, da vaca lechéra, diceva, ossia mucca da latte – immagine che per noi va piuttosto associata alla vache qui ride dell’omonima marca di formaggini fusi – ; che lei strascinava come orecchiette in padella, si sbizzarriva AC nello sghignazzo. L’osservazione oggettiva era che mai Dora usava il reggiseno, che prediligeva il velo, la rete, la scollatura per eccesso e al mare dei bikini che potremmo definire ipotetici, tanto che AC, osservandola scendere in riva dondolando a ogni passo quel peso, arriva Poppalina, mormorava in un orecchio all’amico Pilatus, cui i modi della madre se non di più, certo non erano meno fastidiosi. Repellente, concludevano a due voci i ragazzi e AC rincarava la dose del giudizio senza appello, il mostrarsi senza dimostrarsi è il troppo, diceva, e il troppo è veleno. Affermazione che, per puro caso, coinciderà quasi alla lettera con una simile, letta in un romanzo di fantascienza posteriore di poco a quegli anni loro di ragazzi. Ci sono persone che non ci vanno a genio per una ragione o per un’altra, spesso, e chissà se nella maggioranza dei casi di antipatia, senza ragione. Gli animali, cani, i gatti sono specialisti, provano questi sentimenti senza vergogna, se qualcuno sta loro antipatico, nell’ipotesi più favorevole al soggetto, se ne tengono alla larga. È giusto segnalare che per il motivo contrario a questo disprezzo astioso, potremmo chiamarlo in questo modo, AC sentì tuttavia il dovere, l’imperativo categorico di rispondere con prontezza all’appello muto dell’amico perché partecipasse al funerale – che è un matrimonio al rovescio –. Su un livello più profondo, estetico, termine che AC coniugava a etico e infine a politico, di Dora lui non aveva mai apprezzato l’atteggiamento di libertaria forzata, di donna in apparenza indifferente alle convenzioni e che invece era evidente quanto fosse fissa, eccome, come un dente di drago anticarro, nel terreno borghese ; della sua borghesia di appartenenza e riferimento, notabile, liberale, massonica anche senza grembiulino, protestante ignara di proteste, giansenista – ah Manzoni sappiamo, ma la c’è la provvidenza – erede di un capitalismo pietistico, all’occorrenza radicale, ma mai meno che egèmone anche nelle sue recite sociali ; sempre planante dagli eccelsideo con cui quei notabili pontificavano del reale altrui, il reale effettivo, senza grammatica di complemento delle classi subalterne cui, di fatto erano alieni ; borghesia sempre dominante quindi, che apriva filande e deviava il corso dei fiumi per costruire ricche centrali elettriche ma anche, deo gratias, villaggi operai magari con acqua corrente in casa. Dora era peraltro fiera di un matrimonio con un fuori casta, bello e possibile, della bassa italia ma brillante filosofo, deputato del Partito Comunista, da subito sodale di Rossana Rossanda al Manifesto e morto per tempo così da permettere a lei, Dora, di conservarsi e per non breve periodo come una Penelope vedova accertata e destinata alle bave di un certo numero di proci che AC e Pilatus, senza pudori vedevano alternarsi nel sontuoso appartamento di via Rovani, con offerte di fiori e profferte evidenti di sperma a non più finire.
Di scendere a Milano AC aveva voglia come di andare a far visita ai coccodrilli dell’alto Nilo ma alla famiglia di Pilatus, i Pinti che qui citiamo con un nome di fantasia ché numerosi sono i suoi personaggi e non tutti sarebbero disposti a figurare nello stesso affresco, a questa famiglia – ed ecco gli imperativi che scendono dalla stelle – do-ve-va, doveva la riconoscenza di chi fin da bambino, e oltre l’infanzia fino quasi alla maturità, era stato ospitato qua o là per vacanze lussuose, tra l’altro in quella stessa Celerina, o a Marciana sull’isola d’Elba ; lo avevano aiutato quando lui faceva fatica a districarsi nel mondo del tu-conosci-vero mentre loro quel mondo e i tu-conosci-vero tenevano in portafoglio e ne potevano disporre come carte di credito senza limiti di spesa, sicché AC sapeva benissimo che la brillante gavetta da maestro accompagnatore a Lisbona fino a direttore ospite poi tra Bilbao e la Coruña per anni, e lo sviluppo della carriera, tra direzioni principali e dischi fino al successo dunque, nelle capitali della musica, Vienna per dirne una soltanto, la sua fortuna farla breve la doveva, pel suo indispensabile côté mondano, ai legami di costoro in una vastissima sfera di supposti intellighentes, primari e notai e di sciùre – bábe, damázze, mesdames verdurins dalla lingua lunga e diseguale quanto modesto comprendonio – di cortigiani che agli artisti stanno come su un cranio una corona, di spine non si escluda. I suoi mecenati insomma, i Pinti lo avevano allevato, gli avevano insegnato per così dire a sbucciare la frutta, la banana persino con coltello e forchetta, pur fidando come ovvio nel fato di AC, a detta di tutti un genio e non tanto piccolo. Pilatus, Tus o Pilli era per AC un legame amicale da tutta la vita, quasi, dalla terza elementare ; si noti peraltro che non tutto di Pilatus gli era gradito, non tutto condivideva, non le convinzioni di quest’ultimo che potevano oscillare tra conservatorismo e reazione, nonostante l’attitudine sessuale ; in proposito, ad AC stava cordialmente sullo stomaco il compagno di Pilatus, uno di quegli omosessuali sgargianti benché, diceva di sé, molto credente e, né più né meno di altre Dore convinti di doversi ostentare, pur senza boa ed aigrettes, e che non trascurano un istante della loro esistenza per andare come soprani svociati alla ribalta a regolarsi con gli altri come se fossero di un ragno le prede. Giacomo si chiama il tipo e qui lo citiamo per scartarlo come un pomodoro abbacchiato che si getta via, per non parlarne più. AC a quella classe che non era mai riuscito ad amare e con la quale, nelle sue convinzioni mai si era identificato, nel paradosso dei fatti aveva finito appunto per cascarci : un genio divenuto, oh se lo sapeva, uno di loro, nonostante la distanza connessa con l’equazione artista uguale divino neutrale. Questo moltiplicò, da un certo punto della sua parabola in poi e che coincide con la sua vita, il suo vago sentimento di colpa, come se avesse tradito una categoria di appartenenza originaria, una classe di mezzo, non borghese per censo, non proletaria, non di lavoratori come sono intesi i lavoratori dai sindacati ; tra le cose che lui vedeva con chiarezza, di cui era consapevole dopo tanti anni di militanza tra coloro che pensano alla giustizia dei rapporti sociali, c’era che oggi alla lotta sociale s’era sostituito l’arrivismo sociale, farla facile il pugilato a mani nude per ogni baiocco : vengan quattrini al resto son qua io, sussurra il Don Basilio del Barbiere di Siviglia.
Se l’era portato appresso perché perbacco non riusciva a liberarsi di quell’Enterrements della Rosìni ; lo trasse di tasca e lesse a caso mentre una luna regina della notte sbiadiva tra le cime. Une lune épouvante. Per motivi che non c’è modo di scoprire continuerà a ripetersi durante tutto il viaggio questa quartina, elementare in fondo, ma con quel finale che pare un accidenti e che tradotto sta per sembra un ecchimosi, (un )blu
Une lune épouvante
Au ciel le gros dos mouvante,
Sortie de près de son milieu,
Parait-elle una ecchymose, bleu.
Fine della terza parte